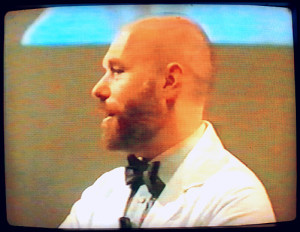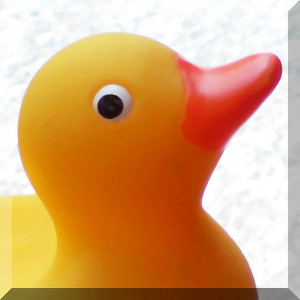Una bella tappa di SelfieChemistry – Foto|chimica alla sede lomazzese del Liceo Fausto Melotti di Cantù. Intanto perché mi fa sempre piacere passarci, sono millanta anni da quando ci insegnavo ed è già un po’ da quando ho visto chiudere la tradizione del glorioso Istituto d’Arte. Poi, perché la sfida è quella di far capire l’importanza della scienza della materia a chi non la incontra più – come era un tempo – tra le materie caratterizzanti del proprio percorso, mentre la chemofobia non si arresta.
Una quinta, abbastanza numerosa: sguardi perplessi o diffidenti di fronte all’idea che per due ore avrebbero sentito parlare di chimica. Addirittura, di cosa c’entra la chimica con la storia degli ultimi secoli, quella che magari ti chiedono all’esame. Ma, forse più che in altri momenti, vedo parecchio interesse che si risveglia. Chimica e storia accompagnati da casi concreti, dalla nascita simultanea della chimica e dell’arte – quando un ominide per la prima volta preparò consapevolmente un qualche tipo di pittura – ai materiali pittorici più prossimi alla nostra cultura, dal Medioevo (e cos’è poi, il Medioevo?) a tutte le tecniche pittoriche recenti che dovrebbero conoscere. Quelle “dalla seconda rivoluzione industriale in poi”, come direbbe un libro di testo, e pazienza se stavolta dovrò lasciare da parte Perkin e la tintura, accontentandomi di Van Gogh folle per i nuovi colori. Fino alle bombolette di acrilico… certo che nessuno di questi fanciulli ne faccia un uso poco responsabile.
E la chimica della contemporaneità, quella che permette di generare, riprodurre, fissare una immagine, su pellicola o in digitale.
Con una parte sperimentale che, una volta di più, fa drizzare le antenne quando entrano in gioco le vecchie signore: la mia Canon F1 eponima, qualche cucciolo mansueto come la Canon Demi o aggressivo come una Perfekta in total black. Cromo, bakelite, acetato di cellulosa, poliestere… e di colpo la ressa quando si tratta di guardare nel vetro dalla Avus, per vedere il mondo capovolto in 9×12. Non abbiamo tempo per un set completo – anzi, grazie alla paziente collega che ci ha consentito di “sforare” con i tempi! – ma se vedere uscire un negativo dalla tank è sempre magico per me, figurati per chi lo vede la prima volta, e magari deciderà che sarà solo la prima di tante.
La cosa bizzarra è che non abbiamo fatto nemmeno un selfie, anzi nessuno si è messo a documentare la lezione, e non è che ci mancasse l’hardware: ma abbiamo una foto del cortile di fronte, e in fondo anche Niepce aveva iniziato così. La comprimo un po’ o la vuoi a 600 megapixi? 😉
e in fondo anche Niepce aveva iniziato così. La comprimo un po’ o la vuoi a 600 megapixi? 😉
Tre idee riassuntive, forse:
– la chimica e l’arte sono due aspetti essenziali, complementari e spesso coincidenti del nostro essere umani
– il mondo è troppo più vasto di quel che si vede a scuola, ma la scuola può essere capace di allargare i tuoi orizzonti
– e già che ci siamo: là fuori ci sono tantissime fotocamere splendidamente funzionanti, che non deperiscono in pochi anni come le costose digitali, che magari ti aspettano nell’armadio del nonno prima ancora di cercarle in rete. Che hanno visto storie grandi e piccole e che meritano di vivere ancora, per fotografare in modo creativo, moderno, economico.
Come direbbe Ollivander, spesso è la macchina che sceglie il fotografo: forza, ti sta cercando. Se è ormai chiaro che il 2017 è l’anno in cui la pellicola ritornò alla grande, tu che fai l’artista non sarai mica così indietro da usare ancora il digitale?

 Il dott. Rossi, storico dirigente della struttura, un giorno mi manda a chiamare e mi chiede se, essendo un insegnante ed un divulgatore, fossi in grado di allestire uno spettacolo di tema chimico. O, insomma, qualcosa di meno ovvio della solita conferenza, per una attività di orientamento verso i ragazzi delle scuole medie, che mostravano sempre meno attenzione per gli Istituti Tecnici o per i Licei Scientifici Tecnologici (bella cosa anche quelli, pace all’anima loro, ma continuiamo a non divagare).
Il dott. Rossi, storico dirigente della struttura, un giorno mi manda a chiamare e mi chiede se, essendo un insegnante ed un divulgatore, fossi in grado di allestire uno spettacolo di tema chimico. O, insomma, qualcosa di meno ovvio della solita conferenza, per una attività di orientamento verso i ragazzi delle scuole medie, che mostravano sempre meno attenzione per gli Istituti Tecnici o per i Licei Scientifici Tecnologici (bella cosa anche quelli, pace all’anima loro, ma continuiamo a non divagare).